Lettura: 7 min • Libri
Libri letti nel 2016
Tre libri che ho consigliato e citato spesso quest'anno
Ogni anno provo a leggere 30 libri. Non ci riesco quasi mai, ma mi ci avvicino quasi sempre. Mi fermo tra i 20 e i 25. Non segno proprio tutto quello che leggo, cerco comunque di essere fiscale: segno solo i libri che ho finito.
Quest’anno ho letto 23 libri, più cinque lasciati a metà, più due che sto leggendo in questo periodo, e che probabilmente finirò prima del 31 Dicembre.
Non sempre abbandono i libri perché non mi piacciono. Capita che li abbandono perché in quel momento non sono più interessato o perché non posso dargli la giusta attenzione. Spesso li riprendo dopo mesi. Ho abbandonato, ma riprenderò, Il liberatore dei popoli oppressi di Arto Paasilinna e La nuova geografia del lavoro di Enrico Moretti. Ci sono alcuni libri che comincio solo per curiosità sapendo già che non li leggerò per intero, anche in questo caso a volte capita che li riprendo. Nella lista degli abbandonati di quest’anno ci sono Purity di Jonathan Franzen, La morte del padre di Karl Ove Knausgård, e Siamo tutti completamente fuori di noi di Karen Joy Fowler.
Come in un post prima dell’estate segnalo tre libri che ho letto in questo 2016, che mi sono piaciuti un po’ più degli altri e che mi è capitato di citare e consigliare spesso. Un’autobiografia, un romanzo (o qualcosa di simile), un libro di “appunti” sulla fotografia mobile.
Sotto ci sono delle citazioni e delle informazioni di base sui libri.
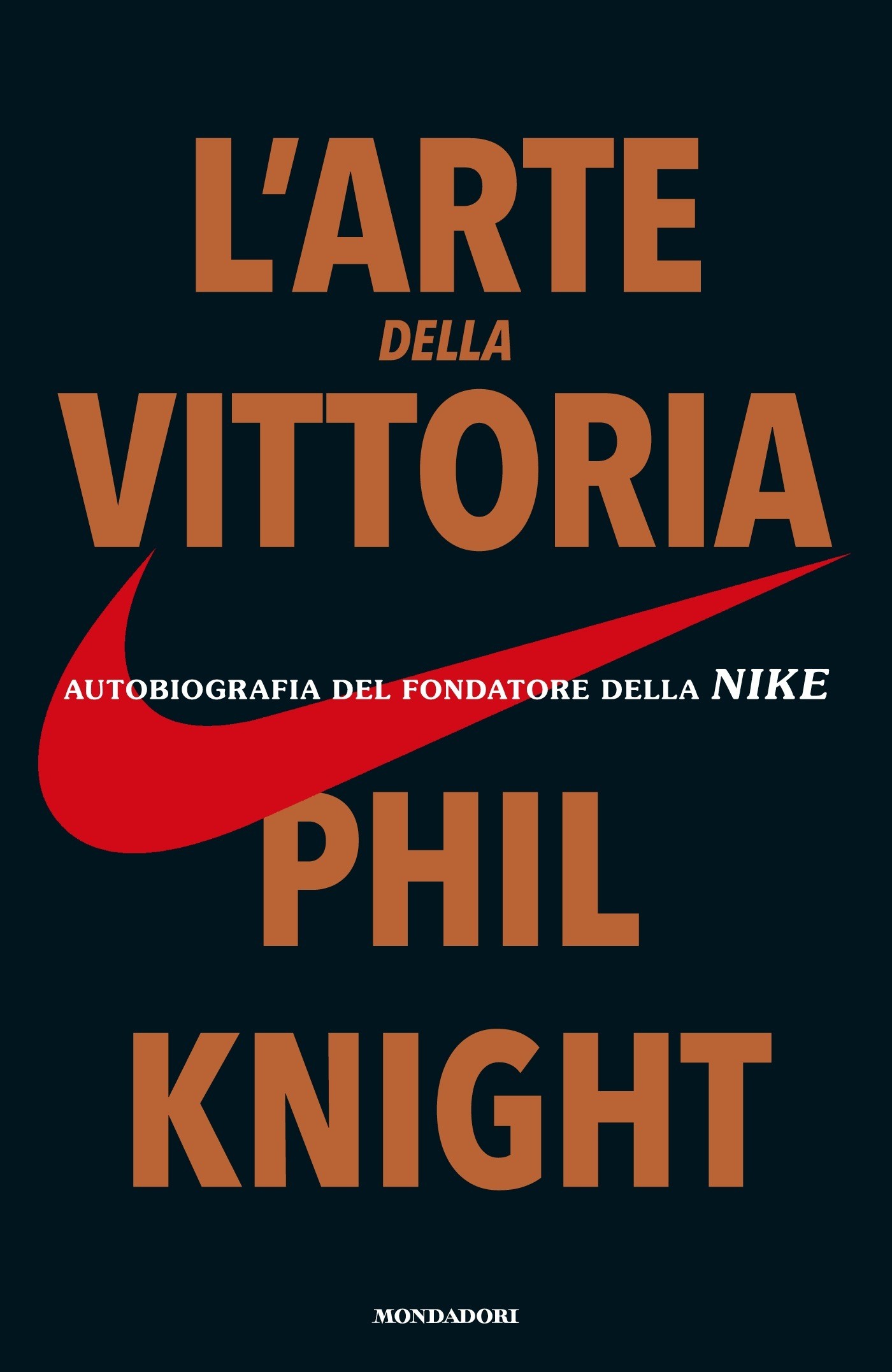
L'arte della vittoria
È l’autobiografia di Philip Knight, il fondatore della Nike. Racconta gli inizi della Nike, quando si chiamava ancora Blue Ribbon è rivendeva le scarpe della Onitsuka Tiger. La storia è interessante e molto onesta. Knight racconta il suo percorso personale, dal suo viaggio in giro per il mondo dopo l’università alle prime vendite. Racconta degli errori, dei problemi, della disorganizzazione, e dell’incredibile entusiasmo e amore per la corsa che ha sempre accompagnato lui e tutte le persone che hanno lavorato con lui in quegli anni.
Non c’è dubbio che un osservatore casuale ci avrebbe visti come una penosa ciurma eterogenea, tragicamente male assortita. Ma nella sostanza c’erano tra noi più punti di contatto che differenze, il che dava coesione agli scopi e agli sforzi comuni. Eravamo quasi tutti dell’Oregon, e questo era importante. Avevamo un bisogno innato di metterci alla prova, di mostrare al mondo intero che non eravamo dei bifolchi di provincia.
Se assumevi un contabile, eri certo che almeno sapesse contare. Se assumevi un avvocato, eri certo che almeno sapesse parlare. Se assumevi un esperto di marketing, o uno sviluppatore di prodotti, cosa sapevi di lui? Niente. Non potevi prevedere cosa avrebbe fatto, e neppure se fosse in grado di fare qualcosa.
Non dire mai alle persone come fare le cose. Di’ loro cosa fare e ti sorprenderanno con la loro ingegnosità.
Parlando di Jeff Johnson, collaboratore di Knight e secondo dipendente della Blue Ribbon:
Dentro di sé era convinto che i corridori fossero eletti del Signore, che la corsa, praticata bene, con lo spirito giusto e la forma adeguata, fosse un esercizio mistico, non meno della meditazione o della preghiera, e si sentiva chiamato ad aiutare chi correva a raggiungere il proprio nirvana.
All’inizio di un capitolo Knight inserisce questa citazione di Pastorale Americana di Philip Roth:
«Nessuna idea brillante è mai nata in una sala riunioni» garantì Stahr al Danese. «Ma in compenso ci sono morte un sacco di idee cretine.»
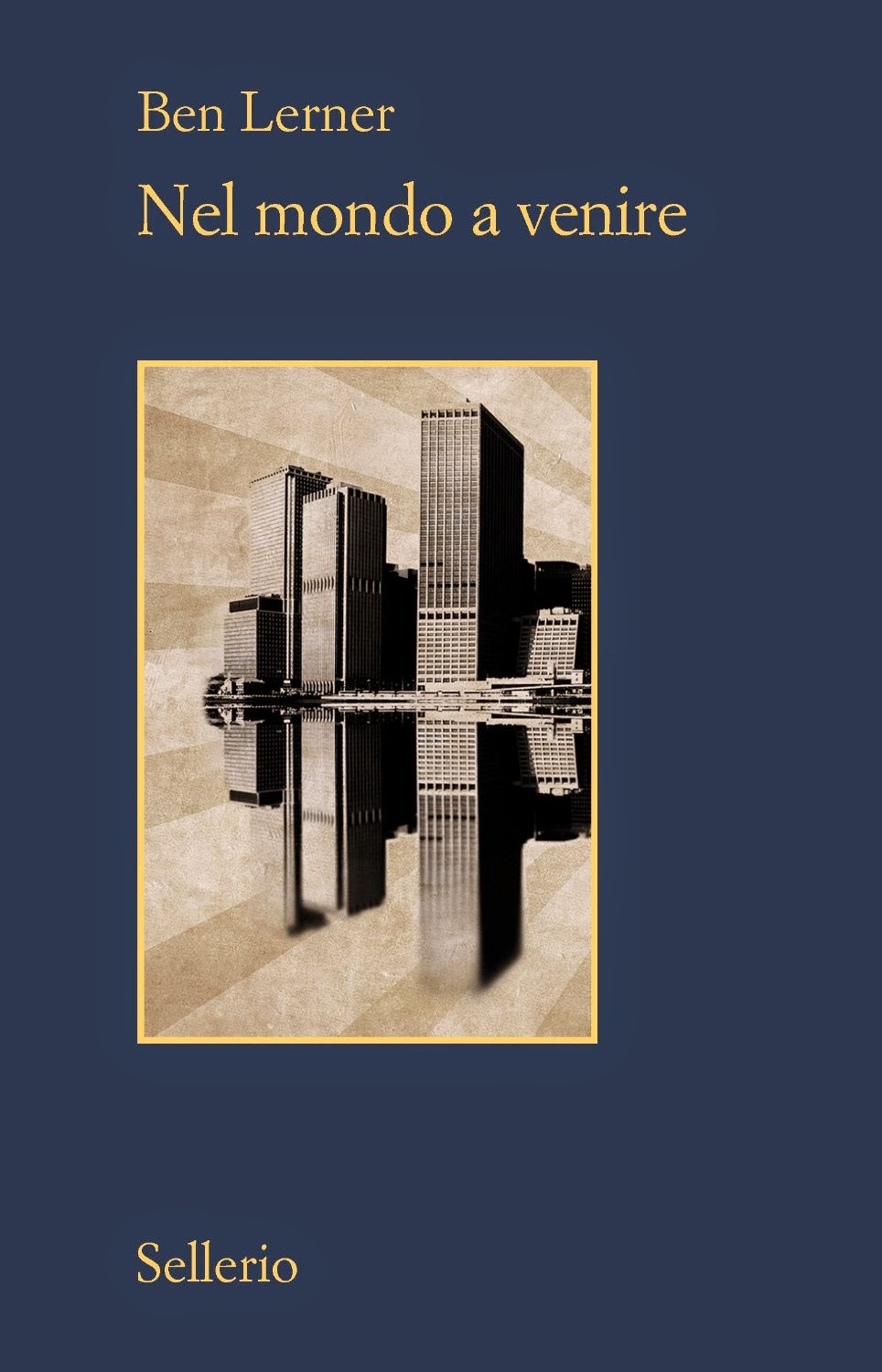
Nel mondo a venire
Il libro di Ben Lerner credo rientri in quella categoria chiamata autofiction. Racconta della vita di uno scrittore che dopo aver pubblicato il primo romanzo, e poi un racconto sul New Yorker, è alle prese con il suo secondo libro. Lo scrittore di cui parla Lerner è se stesso, il libro che sta scrivendo è Nel mondo a venire. Non c’è una trama precisa e lineare, sono una serie di racconti, situazioni, idee che hanno come filo conduttore se stesso.
Molto bella la scrittura di Lerner e come racconta e descrive qualsiasi cosa. A un certo punto Lerner parla di “The Clock”, un video dell’artista Christian Marclay lungo 24 ore — proiettato nei cinema qualche anno fa — che raccoglie spezzoni di film che mostrano l’ora. Tutto in tempo reale. Entrando al cinema alle 17:05 si sarebbe visto un orologio che mostra le 17:05.
Anche Ben Lerner nel libro va a vedere il video di Marclay e racconta di quando a un certo punto controlla l’ora sul telefono:
[…] un gesto assurdo: stavo distogliendo gli occhi da un orologio per guardarne un altro. Provai un po’ di imbarazzo nel rendermi conto di quanto fosse radicata in me quell’abitudine alla distrazione, ma decisi che era un segnale importante, rispetto al video, il fatto che mi fossi dimenticato che mi stava indicando l’ora.
Avevo sentito descrivere The Clock come il collasso più estremo del tempo narrativo su quello reale, un’opera ideata per cancellare la distanza fra l’arte e la vita, la fantasia e la realtà. Ma uno dei motivi per cui avevo guardato il telefono era che per me quella distanza non si era cancellata affatto: anche se la durata di un minuto reale e di un minuto di The Clock erano matematicamente indistinguibili, erano comunque minuti che appartenevano a mondi diversi. Il tempo di The Clock lo guardavo ma non ci ero immerso dentro, o, in altre parole, stavo vivendo lo scorrere del tempo in sé, non vivevo esperienze calate nel tempo.
Guardando Ritorno al futuro:
Marty stava già insegnando a Chuck Berry a suonare il rock ’n’ roll nel passato, il che significava che, al suo ritorno nel futuro, i bianchi sarebbero stati gli inventori di quella forma di musica, non quelli che se n’erano appropriati.
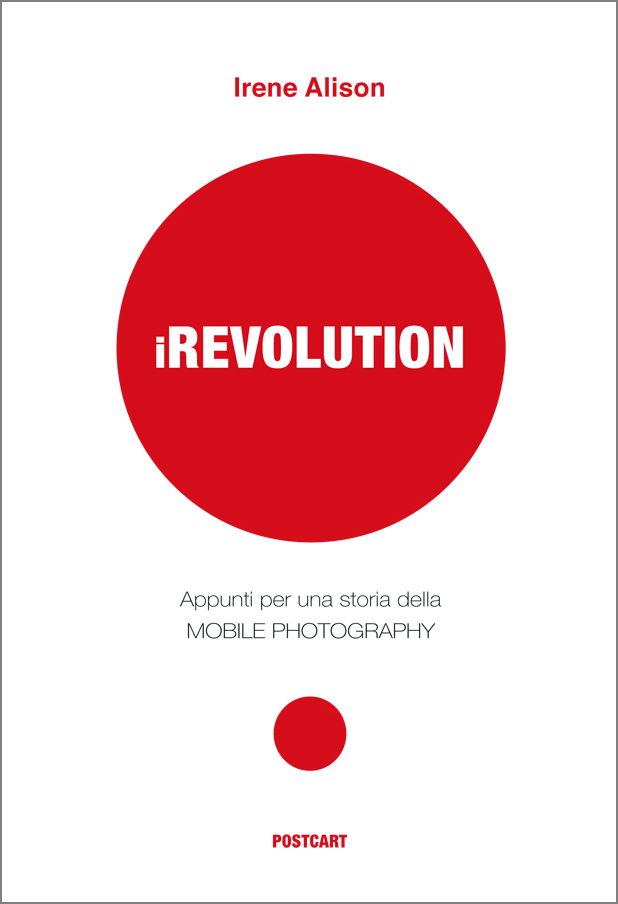
iRevolution
Irene Alison prova a fare il punto della storia (se pur breve) della mobile photography. Un libro, come scrive Alison nelle note di apertura, «per tracciare una mappa delle possibilità e delle prospettive che apre, […] utile se non a trovare la rotta, almeno a capire a che punto siamo».
La fotografia non serve più a fermare il tempo, ma tentare di riprodurlo in streaming: non fotografiamo più per ricordare, ma per condividere, e questo fa della fotografia una pratica continua, immediata, e spesso transitoria.
La relazione tra fotografia e tempo, nell’era smart, assume dunque una sfumatura nuova: le fotografie non testimoniano il passato, ma proiettano il presente verso l’infinito, l’immagine non registra più l’evento, ma diventa parte dell’evento.
L’esperienza della fotografia, nell’era smart, diventa dunque più importante delle immagini stesse: fotografiamo compulsivamente ma raramente riguardiamo i nostri scatti, assegnando un valore di gran lunga maggiore alla pratica del fotografare piuttosto che ai suoi risultati.
Poco prima che l’uragano Sandy si abbattesse su New York nel 2012, Kira Pollak, direttrice del dipartimento fotografico del Time, decise di dare l’accesso del loro account Instagram ad alcuni fotografi per documentare quel momento di quando. Una delle foto condivise su Instagram — quella di Ben Lowy — finì poi sulla copertina del Time. Dice Pollak:
Non siamo tutti fotografi. Piuttosto, siamo tutti testimoni. Le prospettive di singoli possono offrire delle angolature interessanti sulle storie, gli elementi, ma si tratta pur sempre di un’aggiunta che necessita dell’accompagnamento di un racconto giornalistico.
Nella seconda parte del libro Alison ha chiesto ad alcuni fotografi — che fin da subito hanno abbracciato la sfida di questo nuovo strumento — le ragioni delle loro scelte e gli esiti dei loro esprimenti con la produzione e condivisione di fotografia mobile.
Dall’intervista a Richard Koci Hernandez:
Il mio ruolo come fotografo professionista, da quasi trent’anni, è di studiare gli strumenti della visione, giocarci, e continuare a scoprire in che modo io possa usarli per esprimerli senza rimanere aggrappato al passato. Gli strumenti tecnici sono sempre più potenti e più autonomi, ma non bisogna scordarsi che la fotografia ha delle regole: composizione, uso della luce, esposizione, scelta del soggetto, espressività e tanto altro.
Dall’intervista a Benjamin Lowy:
L’uso dell’iPhone sta avendo un grande impatto sul linguaggio visivo: basta pensare che prima si scattava tenendo un occhio chiuso, eliminando così la visuale periferica, mentre ora si scatta guardando il display con entrambi gli occhi. Questo ha cambiato il mio modo di inquadrare le immagini, ed è destinato di sicuro a cambiare il modo delle persone di comporre la loro visione.
Dall’intervista a Radcliffe Roye:
Penso […] che l’opera d’arte non sia affatto una questione di controllo, ma di gestione dell’imprevisto. Nel momento in cui decidi di scattare una foto, il soggetto può modificarsi. Anche in uno studio, dove puoi controllare ogni dettaglio, nel momento in cui scatti qualcosa può cambiare. E questo che fa la differenza, in un’immagine.